Quando un paziente giunge in consultazione non sempre ha le idee chiare sul suo malessere. Ha una stretta al cuore. È immobile. Vede la vita in bianco e nero, ne ha smarrito i sapori. È affaticato, esangue, senza entusiasmo ed energia. Ha un fastidioso sintomo psico-somatico, o più d’uno, un non so che spesso senza nome che gli rende la vita faticosa e buia.
Si tratta, spesso, di un paziente che ha già effettuato i soliti pellegrinaggi diagnostici ma nessun medico ha dato un nome chiaro al suo disagio, tranne nei casi di disfunzioni sessuali che hanno nomi altisonanti come anorgasmia, vaginismo, eiaculazione precoce, e così via.
Ma anche in questi casi, molti medici e monti pazienti si fermano al nome e al sintomo visibile, trascurando l’invisibile, il sommesso.
Alcuni di loro vengono liquidati con la solita frase: “Lei non ha nulla, è solo questione di testa!”; il paziente va via dallo studio del professionista più sconfortato di prima pensando di essere pazzo: un malato di mente.
I sintomi e le parole per dirlo
Il paziente muto giunge in studio invaso e straziato dai sintomi. Da un corpo che duole, da un cuore che non batte più come prima o che non gli ha mai regalato l’ebrezza di un battito.
Porta in seduta parole piene di buio, nebulose, confuse. Manipola il colloquio, cerca di trascinare il clinico nel pantano del suo malessere. I suoi occhi non guardano più, se lo fanno ancora in realtà non vedono. Il suo cuore è chiuso in una gabbia opprimente, non conosce l’origine della sua prigionia e nemmeno la chiave per poterne venire fuori. A volte i pazienti non si rendono conto di quello che succede dentro di loro, di tutto quel fracasso, quel disordine, quell’agitazione, quell’immobilismo, quei sintomi. A volte non riescono a guardare lì dentro – in quel luogo invisibile chiamato inconscio, onirico, psiche, sintomi psico-somatici, depressione, ansia – e i medici sedotti e in religioso ascolto dell’elenco dei sintomi da parte del paziente, spesso, si fermano al corpo, al visibile, all’organico.
I pazienti si vergognano della loro sofferenza, del loro disagio, del loro immobilismo del vivere. Qualunque altra condizione di vita, anche in preda ai sintomi più invalidanti, gli sembra preferibile alla fatica che dovrebbero impiegare per attivare un cambiamento; farebbero di tutto per non affrontare le minacce della loro psiche avversa e sconosciuta.
Navigano senza tregua in acque terribilmente pericolose e agitate, piene di insidie e di vortici, di relitti nascosti, ben custoditi nelle terre profonde e buie dell’inconscio, cercano in tutti i modi di far scivolare la loro vita su una tranquillità che diventa immobilismo.
Le parole che curano e lo spazio della seduta
In seduta le parole che curano hanno un ruolo ancora più decisivo che in altri contesti. Vanno pensate e pesate, misurate, centellinate. Bisogna trovare le parole che in quel preciso momento, non prima, non dopo, hanno la forza di passare dal mio cuore e mente al complesso mondo del paziente o alla coppia. In una prima fase il paziente non ascolta, non parla o se lo fa non dice, non si conosce, magari ha mentito a sé stesso per anni, per decenni, per difendere le sue fragilità o i suoi mostri interni sino a quando non sono diventati sintomi.
Prima intermittenti, poi stabilmente presenti nella sua vita, poi invalidanti.
Ci sono delle volte che il paziente giunge in consultazione perché trascinato contro la sua volontà dalla moglie che lo vede stanco, assente, disamorato, esanime. Manca l’eros, la passione, il desiderio di fare anche le cose più semplici come andare a mangiare una piazza, una partita a tennis o una vacanza. A volte il partner mi racconta che lo vede buio, spento, che pensa che abbia un’altra donna (o un altro uomo, che sia diventato omosessuale), che non lo ami più.
A volte capita che un paziente giunge in studio perché non riesce ad amare. Mi racconta di trovare soltanto uomini (o donne) sbagliati, che gli spezzano il cuore. Che è sfortunato. Paralizzato. Che non sa come si possa fare ad amare ed essere amati. Per poi scoprire durante il percorso che questa paralisi del vivere lo ha protetto dall’angoscia più grande: di rivivere quell’antico e algido legame con la madre e di poter riproporre quel disfunzionale e anaffettivo legame genitoriale.
Consulenza
Quando gli occhi non sono più finestre. La teoria di Giordana, una donna dissolta e il suo prurito devastante
Giordana giunge in studio con un corteo sintomatologico confuso. Aveva un prurito devastante che le faceva compagnia a inizio giornata e a fine giornata, quando Giordana iniziava a rallentare e a smettere di lavorare. Si grattava talmente tanto le braccia e le gambe da creare delle lesioni, e smetteva quando il dolore superava il prurito. Il giorno dopo ricominciava. Aveva iniziato a dormire poco, male, a non dormire più. Non ricordava i suoi sogni; sosteneva di non sognare proprio.
Aveva un malessere che le stringeva il petto e impediva al suo cuore di battere. Si era rintanata in un silenzio dei sensi difensivo, non faceva l’amore, non voleva essere accarezzata dall’uomo con cui viveva, faticava e stentava a rallentare.
Giordana era diventata invisibile a sé stessa. Una donna dimenticata, invisibile, dissolta.
Ascoltarla mi faceva venire in mente “l’Io pelle”, quel meraviglioso libro dello psicoanalista francese Didier Anzieu, nel quale descrive la superficie del corpo – la pelle – come un costituente cruciale delle strutture e delle funzioni della mente.
Nel bambino, durante i primi stadi di sviluppo, quando è del tutto inconsapevole dei propri confini corporei, percepisce la pelle della madre o di chi si occupa di lui come propria; sperimenta ciò che Anzieu chiama la fantasia di una “pelle comune”.
Questo accade da adulti a chi ama troppo e poco sé stesso, a chi ama male, in maniera eccessiva e parassitaria. A chi ha una dipendenza affettiva, a chi non mantiene la giusta distanza tra il proprio mondo interno e quello esterno; esattamente come accadeva a Giordana. La donna che amava troppo.
Il ponte di parole
Il ponte di parole che si crea in terapia – che sia individuale o di coppia – conduce il paziente in nuove terre, spesso mai esplorate prima. Lo prende per mano, con garbo, gradualità e competenza, per mostragli nuovi orizzonti. A piccoli passi, con lentezza, senza consegnare alla fretta la guarigione.
Usare bene le parole significa edificare un ponte fra l’agitazione e la calma, tra lo scuro e il chiaro, il buio e la luce che inizia finalmente a intravedersi oltre il sintomo offerto. Così, pian piano, il paziente che in una prima fase parlava soltanto di ansia, di quel buco che gli impediva di respirare e di amare, della sua erezione zoppicante e intermittente, dell’eiaculazione o dell’orgasmo ritardatari o assenti, inizia a spostare lo sguardo dal sintomo a quello che c’è dietro e dentro il sintomo.
Quel ponte edificato in terapia – mattone dopo mattone, seduta dopo seduta, lacrima dopo lacrima e sorriso dopo sorriso -, fatto di parole, lo condurrà dal passato doloroso e rimosso a un presente affettuoso e generoso. Dal buio alla luce. Dall’immobilismo all’azione. Dal si deve al so quello che voglio. Dai dictat genitoriali alle sue nuove leggi del cuore.
Per gli innamorati delle parole, per i fragili, per i bisognosi di verità assolute, per gli affamati di meraviglie, le parole hanno una vita propria, esattamente come le persone.
Si incontrano durante il cammino, a volte vengono ignorate, non scatta la scintilla amorosa, altre volte vengono catturate perché quella parola e non quell’altra entra dal buco della serratura e arriva dall’altra parte del muro, in profondità.
Quella parola, in quel preciso momento della vita del paziente e anche di chi cura, accende una luce, si fa luce, e illumina il cammino.
Poi, pian piano, nel tempo, quella parola, esattamente come un seme, germoglia, si espande, mette radici. Da lei ne nascono altre e con loro nuovi pensieri e nuove emozioni, e dopo nessuno sarà più uguale a prima.
Passare attraverso le parole, intrufolarsi tra le lettere e le frasi, è come camminare in mezzo alle persone. Rimangono addosso le espressioni, le forme, i chiaroscuri, delle sfumature linguistiche che si incastonano a lungo nella nostra memoria e nel nostro cuore.
Quelle parole si fissano lì, si incastonano, non si sa bene perché, perché in quel momento della nostra vita? per quale motivo? cosa ci vogliono dire? dove ci vogliono condurre? da dove ci vogliono togliere? quale sofferenza ci vogliono alleviare? Sono entrate dentro di noi, e da quel momento iniziano a lavorare duramente.
A volte le sensazioni e le emozioni, anche quelle inedite che non pensavamo di poter provare, iniziano ad esistere proprio grazie alle parole, a quella parola e non a quell’altra. A quella parola alternata a quello spazio di silenzio, di sguardi, di occhi che si inumidiscono di commozione. Ci sono coppie e famiglie mute, luoghi del silenzio, dell’astio fatto silenzio, della mancanza delle emozioni che accarezzano. In quei luoghi dove non germogliano le parole sarà difficile poi imparare ad amare, a gioire, a dire. In quei luoghi si impara a stare zitti, e i sintomi talvolta prendono il posto delle parole.
A me capita spesso dopo le sedute, che alcune parole decidano di abitarmi senza chiedermi il permesso: mi torturano, non mi lasciano più, mi strappano al sonno e mi aspettano al risveglio. Vogliono essere catturate e non vogliono andare via da me. Esigono un ascolto attento e profondo.
Alla fine capisco che hanno vinto loro: le metto su carta e le trasformo in sentimenti e racconti. E così ci acquietiamo: loro e io.
Le parole che riparano che si usano in terapia salvano dal mare dell’inesprimibile e trasformano i sintomi in guarigione. E salvano la vita e la coppia.





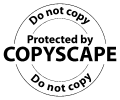


4 Commenti. Nuovo commento
Cara dott.ssa, mi ha molto colpito il suo articolo sull’importanza delle parole. Mio marito, a seguito di un litigio, afferma di aver chiuso con me e non mi parla da circa due anni. Non prende decisioni, si è chiuso in un mutismo ed immobilismo da far spavento. Ho provato in tutti i modi a cercare di farlo aprire o a prendere una decisione, niente da fare. Lei dirà, puoi prenderla te una decisione! Non è così facile quando si sente di avere ancora un legame con questo uomo che è stato il tuo compagno di vita per ben 37 anni e con il quale hai messo al mondo due figlie, oggi adulte e meravigliose. Un uomo con il quale condividi una casa costruita insieme e con il quale svolgi la stessa professione nello stesso studio. È giusto ripartire da zero a 54 anni pur non volendo? Solo perché lui ti porta con il suo silenzio ed immobilismo a prendere una decisione al suo posto e che tu non avresti mai pensato di dover prendere? Grazie per l’ascolto. Buona giornata Simona
Cara Signora,
due anni sono un’altra vita. Sarebbe più utile passare da un terapeuta di coppia prima di andare a finire da un legale, ci provi ancora, se può, magari gli scrive.
Altrimenti si ribelli. Il silenzio uccide!
Un caro saluto
Cara Dottoressa,
le sue “Parole” sono un balsamo per il mio cuore. Sono entrate dal buco della serratura. Grazie
Grazie a lei, Elisabetta, per le belle parole.